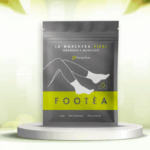Negli ultimi anni la ricerca medica ha rivoluzionato l’approccio al trattamento dell’asma, una delle più diffuse malattie respiratorie croniche a livello globale. Oggi, accanto alle tradizionali terapie inalatorie, si sono affermati farmaci di ultima generazione, capaci di agire su specifici bersagli molecolari all’origine dell’infiammazione bronchiale. Tra questi, gli anticorpi monoclonali rappresentano una delle più rilevanti innovazioni non solo per l’asma grave, ma per tutta la gestione delle forme difficili da controllare con i comuni medicinali.
Cosa sono gli anticorpi monoclonali e come funzionano
Gli anticorpi monoclonali sono proteine biotecnologiche prodotte in laboratorio e progettate per legarsi selettivamente a specifiche molecole coinvolte nei meccanismi infiammatori delle vie aeree. La loro azione è quindi mirata: invece di agire in modo aspecifico sulla risposta immunitaria, come fanno molti farmaci tradizionali, intervengono “a bersaglio” per neutralizzare alcune delle principali sostanze responsabili della cascata infiammatoria che provoca broncocostrizione, tosse e respiro sibilante nei pazienti asmatici.
I principali target terapeutici sono rappresentati da interleuchine (come IL-4, IL-5, IL-13) e dalle immunoglobuline E (IgE), elementi chiave nella genesi e persistenza dell’infiammazione allergica delle vie respiratorie.
Le diverse molecole attualmente disponibili, o in fase di sperimentazione, agiscono per esempio:
- bloccando le IgE, riducendo la risposta allergica (come omalizumab);
- inibendo l’interleuchina-5, con conseguente diminuzione degli eosinofili, una popolazione di globuli bianchi coinvolti nell’infiammazione (mepolizumab, benralizumab, reslizumab);
- contrastando interleuchine come IL-4 e IL-13, diminuendo l’infiammazione e migliorando la funzionalità respiratoria (dupilumab).
Queste strategie terapeutiche consentono di intervenire anche nelle forme di asma che si associano a eosinofilia o risposta allergica, le più complesse da trattare con i broncodilatatori e corticosteroidi standard.
Quando vengono utilizzati gli anticorpi monoclonali
L’introduzione degli anticorpi monoclonali ha permesso una significativa evoluzione nei casi di asma grave, ovvero forme caratterizzate da:
- ricorrenti crisi respiratorie nonostante l’adozione di terapia inalatoria massimale e corticosteroidi sistemici;
- necessità frequente di ricoveri ospedalieri o ricorso ad alte dosi di farmaci;
- presenza di elevate concentrazioni di eosinofili o di IgE nel sangue;
- documentata sensibilizzazione ad allergeni specifici e inadeguato controllo dei sintomi.
Questi farmaci sono raccomandati quando le terapie convenzionali non raggiungono gli obiettivi di controllo clinico o causano effetti avversi significativi. Grazie alla loro efficacia selettiva, gli anticorpi monoclonali possono ridurre le riacutizzazioni, diminuire i ricoveri e migliorare nettamente la funzionalità polmonare e la qualità della vita nei pazienti idonei.
I nuovi anticorpi monoclonali in via di sperimentazione
Oltre alle molecole già in commercio, sono in fase avanzata di studio ulteriori anticorpi monoclonali di ultima generazione. Tra questi figurano lunsekimig, in fase di valutazione sia per l’asma moderata che grave, e itepekimab, un anticorpo anti-IL33 destinato a pazienti con infiammazione particolarmente amplificata, sui quali potrebbero dimostrarsi efficaci laddove altri trattamenti hanno fallito.
Si sta inoltre esplorando l’attività di molecole come amlitelimab, che si prefiggono di funzionare anche nei pazienti con pattern infiammatori atipici o eterogenei, non necessariamente riconducibili alle tipiche alterazioni eosinofiliche o allergiche. Questi studi potrebbero aprire la strada a trattamenti ancora più personalizzati, adattabili ai profili immunologici del singolo paziente.
La pipeline di ricerca è attualmente ricca di sperimentazioni cliniche, come lo studio di fase II AIRCULES (risultati attesi nel 2026) e gli studi AIRLYMPUS, AERIFY-1, AERIFY-2 e AERIFY-3, che valuteranno efficacia e sicurezza di questi nuovi anticorpi sia nell’asma che nella BPCO e nella rinosinusite cronica associata o meno a poliposi nasale.
Evidenze di efficacia e prospettive future
Nella pratica clinica, l’uso degli anticorpi monoclonali è riservato a pazienti selezionati, previa attenta valutazione del fenotipo della malattia, del profilo di rischio e delle caratteristiche individuali della risposta infiammatoria. Gli studi più recenti hanno dimostrato che questi farmaci sono in grado di:
- ridurre di oltre il 50% la frequenza delle riacutizzazioni gravi;
- migliorare stabilmente i parametri funzionali polmonari;
- diminuire la necessità di steroidi sistemici e i relativi effetti avversi;
- incrementare la percezione di benessere e qualità di vita riportata dai pazienti.
Alcuni dati suggeriscono un ruolo anche in ulteriori condizioni a componente infiammatoria eosinofilica, tra cui BPCO eosinofilica e bronchiectasie.
È importante sottolineare che la risposta a queste terapie può essere molto variabile e dipende da una serie di fattori, tra cui il grado di infiammazione, la presenza di eosinofilia, la sensibilizzazione allergica e la tollerabilità individuale. Le linee guida internazionali raccomandano quindi una selezione attenta dei candidati, anche attraverso test biologici specifici per individuare i sottotipi di asma che più probabilmente beneficeranno di queste innovazioni.
In sintesi, la rivoluzione degli anticorpi monoclonali nell’asma sta aprendo la strada a una medicina respiratoria sempre più personalizzata, nella quale il trattamento non è più “unico per tutti”, ma modulato secondo la biologia della malattia e le esigenze caratteristiche di ogni persona. Le prospettive future si basano su farmaci ancora più mirati, combinazioni intelligenti con le terapie tradizionali e strategie di monitoraggio data-driven, potenziate dall’uso di biomarcatori e intelligenza artificiale clinica.